Max Kestner, regista danese dal talento visionario, ci propone un’avventura cinematografica che parte da un evento concreto — la morte di Marius, una giovane giraffa uccisa a Copenaghen — per interrogarci sulle grandi questioni dell’esistenza: qual è il significato della vita, della morte e di tutto ciò che ci circonda?
Con un approccio energico e immaginativo, Kestner realizza un film che mescola riflessione, emozione e sperimentazione formale.
Life and Other Problems ha conquistato la giuria della prima edizione del festival Terra Lenta, dedicato al documentario ambientale in Basilicata, aggiudicandosi il premio principale.
Abbiamo incontrato il regista per farci raccontare come è nata questa idea e quali domande profonde il film cerca di sollevare.

L’origine del documentario
Come è nata l’idea di realizzare questo documentario? Cosa l’ha ispirata e come ha preso forma la visione iniziale?
L’idea è nata quando un produttore mi ha chiesto di raccontare la storia di Marius, la giraffa. Guardando il materiale, però, ho capito che per me quella “storia” non esisteva davvero. Le storie sono dentro di noi, negli esseri umani, e cambiano a seconda di chi le racconta. Un altro regista avrebbe potuto fare un documentario sul ruolo dei media o sull’impatto psicologico di certi eventi.
Io invece ho visto domande più profonde: cos’è la vita? Come ci connettiamo con gli altri esseri viventi? Per questo dico sempre che questo film è un autoritratto. Marius non è una storia, era un essere vivente, e la sua morte un fatto. Le storie nascono dentro di noi, nel modo in cui reagiamo. Se non ci fosse stato Marius, probabilmente avrei raccontato qualcosa di simile con altro materiale, perché era un tema che sentivo dentro.
Quando ho visto quel materiale, ho percepito un’energia molto forte: emozioni intense, urla in televisione, caos e confusione. Ho deciso di usare questa energia come struttura del film, uno scheletro narrativo abbastanza solido da sostenere il racconto.
Dentro quella struttura però ho voluto inserire anche il dubbio, la confusione e l’ambiguità, senza perdere coerenza. Avrei potuto fare un documentario lineare e rassicurante, come quelli americani, ma non era quello che volevo.
Mi interessava creare qualcosa di aperto e flessibile, come un mazzo di carte da rimescolare, un film vulnerabile che non pretende di avere tutte le risposte. È in questa fragilità che vedo la verità più autentica del progetto.
Vita, morte e consapevolezza: ripensare il nostro ruolo nell’ecosistema
In che modo pensi che la storia di Marius e le riflessioni sul ciclo vita-morte possano aiutarci a ripensare il nostro ruolo nell’ecosistema globale o nella società?
Per me è stato come aprire gli occhi su qualcosa di profondo: se ogni cellula del mio corpo ha una sua volontà e può agire liberamente, allora anch’io, che sono più della somma delle mie parti, devo avere una mia volontà. Perché no? Sono almeno quanto una singola cellula, anzi, sono un essere completo. Se una cellula può generare, creare, scegliere, allora anch’io posso farlo.
Questo significa che le mie azioni nel mondo contano. Posso avere un impatto. Posso fidarmi delle mie relazioni e impegnarmi a renderle sane e autentiche. Come individuo posso fare questo: valorizzare i legami umani e riconoscerne la forza.
So che la scienza oggi dice che potremmo non avere libero arbitrio, che tutto è determinato. Ma per me questa visione è incompleta. Anche se contiene del vero, non spiega il nostro sentire e il desiderio di scelta.
Credo che ogni nostra azione abbia un peso morale. Ci sono gesti giusti e gesti sbagliati. E, oggi, forse il gesto più giusto è preoccuparci delle generazioni future, assicurarci che possano ancora abitare questo pianeta. È meglio che restare immobili.
Dobbiamo avere fiducia: abbiamo una volontà, possiamo scegliere e, scegliendo, cambiare il corso del futuro. Siamo un po’ come viaggiatori del tempo: ogni decisione di oggi costruisce ciò che verrà.
Coscienza ed etica: riflessioni sulla linea sottile
Il documentario mette in discussione la linea tra vita e non-vita, tra coscienza e automatismo. Quali implicazioni etiche pensi emergano da queste riflessioni?
Penso che il modo in cui guardiamo alla vita — ciò che definiamo “vita” — sia ancora troppo ristretto. Sembra sempre che altre forme di esistenza sfuggano alla nostra comprensione abituale. Spesso pensiamo che l’essere umano sia unico, ma ogni volta che scopriamo qualcosa di nuovo, vediamo che un’altra specie fa cose che credevamo solo nostre.
Questo succede in continuazione, in un ciclo che si ripete.
Uno dei problemi oggi è che abbiamo danneggiato profondamente gli ecosistemi, ma sembra quasi che abbiamo accettato questa distruzione come normale. Il vero problema è che continuiamo ad agire come se il nostro comportamento non avesse conseguenze.
Anche la politica spesso non ci aiuta, non interviene dove serve. Ma parte del problema è dentro di noi, nel nostro modo di pensare e di rapportarci al mondo.
Credo che dobbiamo tornare ai valori fondamentali che esistono in ogni essere vivente: dignità, connessione, interdipendenza. Cos’è la vita? E cosa non lo è? Sono domande difficili.
Ma come possiamo cambiare le cose se per primi non crediamo nel valore della vita?
Molti non ci credono veramente, o almeno non nella vita di una foresta o di una roccia, o nell’idea che la natura ci accolga e ci rispetti. Ma forse è proprio da lì che dobbiamo ripartire: nel riconoscere che la vita non riguarda solo l’esperienza umana. È qualcosa di condiviso e merita il nostro rispetto.
Questo cambio di consapevolezza potrebbe essere il primo passo verso un vero cambiamento.

Scienza, filosofia e sentimento: trovare l’equilibrio nella comprensione della vita
Il documentario affronta il legame tra scienza e filosofia, realtà e sentimento. Come possiamo trovare un equilibrio tra queste diverse modalità di comprendere la vita? E come possiamo restare fedeli a noi stessi in un sistema che spesso ci allontana dal sentire?
Nel caso di Marius, la scienza sembrava ridurre relazioni ed emozioni a semplici fantasie. Ma io non credo sia così. Credo nella scienza, non ho nulla contro di essa, ma trovo pericoloso trasformarla in un’ideologia.
Dentro ogni essere umano c’è una sorta di bussola interiore che ci guida nel distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. A volte ci si può confondere, certo, ma quella bussola resta.
Non so come funzioni per ognuno, perché abbiamo visioni diverse. Ma per me sentire e incontrare davvero le persone è la base di ogni relazione. E non vedo motivo per non fidarsi di questo.
È importante difendere questa dimensione, perché la scienza studia l’essere umano, ma l’essere umano ama. E l’amore conta.
Io credo che ciò che sentiamo sia reale. Esiste.
E il senso, per me, sta nel cercare di comprendere la complessità di ciò che esiste. Ci sono tanti modi di essere vivi.
Dobbiamo fidarci di tutti questi modi — non solo della scienza, non solo dei sentimenti — ma abbracciare entrambe le cose.
La vita non è semplice. Siamo piccoli, abbiamo poco tempo. Ma in quel tempo possiamo rispondere alla vita, in quasi ogni ambiente, riconoscendo che non siamo soli e che l’esistenza è condivisa.
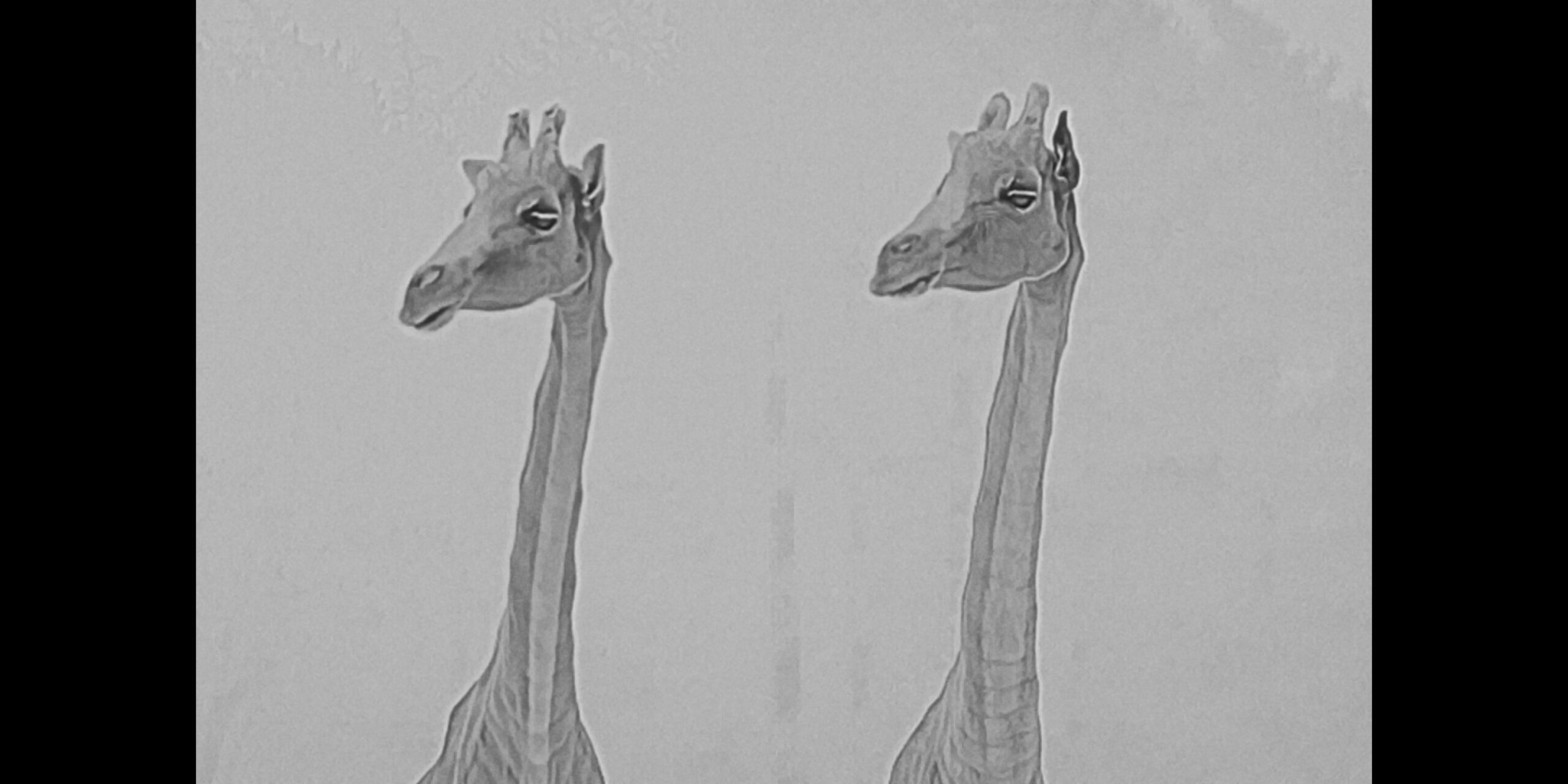
Raccontare la complessità: come bilanciare chiarezza e riflessione
La narrazione del film a tratti è fluida e in altri momenti sembra dispersiva, quasi a riflettere la complessità delle domande trattate. Come hai lavorato per mantenere l’equilibrio tra profondità e accessibilità?
Il film pone una domanda enorme: qual è lo scopo della vita sul pianeta? E qual è il senso della mia vita?
Sono domande a cui nessuno ha davvero risposta. Nemmeno la scienza.
E cento anni fa, quando la religione ha perso influenza, siamo rimasti un po’ più soli davanti a queste questioni.
Viviamo in un’epoca senza risposte assolute, e questo rende tutto più instabile ma anche più autentico.
All’inizio non pensavo di rivolgere queste domande direttamente agli scienziati, ma poi ho visto che poteva aprire porte, per me e per chi vede il film. Forse qualcuno si sentirà meno solo a farsi certe domande.
La morte di Marius è solo un punto di partenza per parlare di empatia, identificazione con altre specie e della nostra posizione nel mondo.
Io non sono una persona che ha tutto chiaro o ordinato nella testa. Non volevo spiegare qualcosa. Volevo dipingere un ritratto, usare immagini, musica, intuizioni. Per questo il film può sembrare confuso, come lo è spesso l’essere umano.
Il mio obiettivo era creare un flusso di coscienza in cui lo spettatore potesse rispecchiarsi.
Il film è una conversazione. Un modo per dire: “Guarda, anche io mi faccio queste domande”. Forse così si crea uno spazio comune per riflettere insieme.
Oltre il mito: come riconoscere una forza che unisce tutte le specie
La reazione globale alla morte di Marius ha sollevato domande sull’empatia e sull’identificazione con altre specie. Come si può integrare nel mondo moderno l’idea di una forza più grande che ci unisce, senza cadere nella superstizione o nel mito?
Non ho una risposta definitiva, ma posso offrire una riflessione. Credo che la chiave stia in come sentiamo e viviamo le relazioni. Un essere vivente completamente privo di legami probabilmente non è nemmeno vivo. La vita è connessione.
Tutto ciò che è vivo fa parte di una rete più grande. E forse proprio in questa interdipendenza possiamo riconoscere una forza comune, non religiosa o mitica, ma una percezione concreta e quotidiana.
Io non sono religioso, ma penso che molti messaggi fondamentali delle religioni — come l’invito ad amare ciò che ci circonda — siano in fondo un modo per dire che siamo parte di qualcosa di più ampio.
La scienza oggi non ha tutte le risposte e forse non potrà mai darci quelle sul senso ultimo. Ma ciò che sentiamo in certe situazioni è reale. A volte, anche solo stare accanto a un animale crea una relazione senza bisogno di spiegazioni. Non è superstizione, è esperienza diretta.
Credo che in futuro la scienza potrebbe riconoscere queste connessioni come parte della realtà. Il mondo è molto più complesso di quanto possiamo misurare. Alcune risposte passano dalla nostra capacità di percepire, sentire e riconoscere che siamo parte di un tutto.
Non sempre faremo la scelta giusta, ma fidarsi di questo sentire può aiutarci a orientarci meglio.