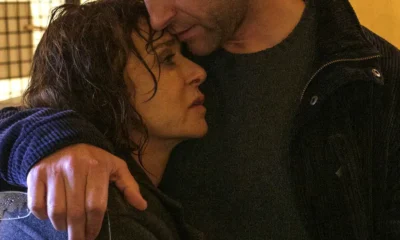Nel Settembre del 2012 cadevano i 100 anni dalla nascita di Michelangelo Antonioni. Ci piace ricordarlo (la sua amata Ferrara gli sta dedicando a Palazzo dei Diamanti fino al 9 Giugno una bellissima mostra) con un film poco noto, ma non per questo meno utile e prezioso per capire i nostri travagliati e caotici tempi, in cui alla precarietà economico-sociale (per non parlare di quella politica) si associa sempre più un malessere esistenziale complessivo e generalizzato, un’incapacità di sentire ed approcciare praticamente il mondo che ci circonda davvero difficile da giudicare nella sua totalità.
Un’evanescenza sentimentale, un caos emotivo alla ricerca di un qualcosa in grado di ridare ordine ed identificazione ad una realtà che ne è priva; un vivere, o meglio sopravvivere, “a mezz’aria” senza concreti punti di riferimento affettivi e sociali, in cui si imbatte anche il protagonista di questo film, uno dei più simbolici e allo stesso tempo maggiormente legati alla cronaca quotidiana di Antonioni.
Niccolò Farra (interpretato da uno straordinario e poco riconosciuto Tomas Milian, che ha da poco compiuto 80 anni!), regista affermato ma in crisi d’ispirazione, torna a casa dopo uno dei suoi viaggi. Ad attenderlo c’è una brutta sorpresa. Un oscuro personaggio gli intima di non vedere più la sua nuova donna, Mavi Lupis (Daniela Silverio), giovane e affascinante ragazza aristocratica. Curioso, tenta di indagare ma le pressioni aumentano. Intanto la loro storia inizia a naufragare; troppe le differenze tra i due. Una sera Mavi sparisce nel nulla senza dare spiegazioni. Niccolò non si dà per vinto, la cerca e dopo numerosi tentativi la trova a casa di un’amica. Ma quando capisce che Mavi preferisce non vederlo più tronca ogni rapporto. Parallelamente, sempre alla ricerca di quel “sentimento” astratto ed indefinito, di qualche suggestione femminile attraverso cui concretizzare un nuovo film, si imbatte in un’altra donna, Ida (Christine Boisson), anch’essa proveniente dall’aristocrazia, ma lontana ormai da anni dall’ambiente natio. Con lei le cose sembrano andare bene, l’intesa – anche fisica – sembra funzionare ma gli strascichi di una storia precedente, di un passato invadente porranno fine alla loro storia. Niccolò, dunque, non può che tornare a ricercare la sua donna ideale.

Schematicamente, senza entrare troppo nel dettaglio, sono tre a mio avviso i motivi di interesse di questo film.
Il primo è che in questo film Antonioni va oltre il tema classico dell’incomunicabilità e dell’alienazione (che ha fatto la fortuna della sua famosa tetralogia degli anni ’60) , riflettendo in profondità sulla capacità stessa degli uomini e in modo particolare di una coppia (che è sempre la sintesi, più o meno indovinata, tra due mentalità, due modi di agire e di pensare) di percepire, sentire, vivere la realtà e il mondo che li circonda. Il malessere odierno quindi è duplice. Da una parte vi è la ricerca sempre più caotica e confusa – dal vago sapore beckettiano – di un qualcosa di etereo ed indefinito che possa, in qualche modo, “indicare la strada”; una sorta di messianesimo laico di impronta kafkiana che dia una speranza al ‘senza speranza’, ordine al caos terreno. Ma dall’altra, e sta qui il paradosso dialettico, non solo si è ormai incapaci di coglierlo ma se riuscissimo a rintracciarlo sarebbe del tutto inutile, dato che il problema risiede nella contraddizioni insolubili, nei limiti, nelle mille influenze, più o meno negative, dalle infinite sollecitazioni, più o meno aggressive, che l’uomo storico-sociale subisce ogni giorno. La questione dunque è il rapporto concreto tra uomo e mondo, tra ciò che l’uomo può ancora dargli e ciò che il mondo gli può ancora donare, senza farli cadere tutti e due in un vicolo cieco. Come l’uomo è in grado di viverlo realmente senza rifuggiarsi in paradisi concettuali ed artificiali, primo fra tutti il cinema. Ed è significativo come in questo film Antonioni utilizzi il suo amato cinema (arte sociale per eccellenza) per denunciarne l’evanescenza cronica, la sua oggettiva argillosità nei confronti della brutale spietatezza della vita, della fine senza senso né ritorno di un sentimento, della morte della poesia, l’illusione ottica di un realtà “altra” indotta non solo negli spettatori ma anche in chi lo fa e lo vive da protagonista, dietro la macchina da presa. La necessità dunque di ritornare alla verità inesauribile della realtà, all’analisi critica di un mondo sempre più impenetrabile, andando oltre la deformazione visiva e percettiva del cinema, risulta essere non più procrastinabile, data le urgenze e le pressioni sociali quotidiane a cui l’uomo è sottoposto.
Non si tratta certo in Antonioni di un cinema “verità”. Ma senza dubbio di riflettere e sottolineare l’urgenza di bypassare tutto ciò che ostacola l’uomo (e la coppia come unità in perenne crisi) dalla comprensione della realtà, distinguendo finalmente ciò che è bene da ciò che è male, lasciando però sempre sospesa la decisione finale. Non siamo dunque di fronte ad un film moralista; tutt’altro. Semmai ad un film in cui l’eticità del vivere quotidiano torna come un’annosa questione non più rinviabile. Per questo, a mio avviso, il problema dell’incomunicabilità e dell’alienazione, che ancora si respira a tratti, viene riassorbito e ridefinito dal tema centrale del rapporto uomo-realtà, uomo-storia, uomo-quotidiano; un quotidiano saturato dalla meccanica (non sempre fluida) dell’amore, dei sentimenti e del sesso, in quanto termometro esistenziale, tempo-spaziale decisivo attraverso cui misurare lo stato di salute della nostra società.

In secondo luogo, Antonioni, assieme al grande sceneggiatore Gerard Brach (con cui scrisse il suo capolavoro Professione: reporter) e l’amico Tonino Guerra, individua nella coppia, nel rapporto di per sé complesso ed ondivago tra uomo e donna, il topos privilegiato di una crisi linguistico-sentimentale (potremmo dire anche erotico-onirica, in un momento storico in cui la sessualità meccanica vissuta come “sfogo” delle pulsioni domina incontrastata, uccidendo ogni gioco emotivo alternativo), che investe tutta la società nel suo complesso. Non è naturalmente un tema nuovo. Ma sorprendono, secondo me, le modalità registiche e di messa in scena scelte da Antonioni per rappresentarlo. Non vi è una pura e sempre impossibilità nel comunicare, come negli anni ’60, in cui tuttavia le parole erano chiare così come gli obiettivi prefissati, in cui il silenzio “non pesava” e poteva essere considerato una scelta “rivoluzionaria”, di rottura (pensiamo solo all’elogio della pagina bianca di Mallarmé citato dal critico in 8 e ½ di Fellini) nei confronti della tradizione verbosa italiana e dalla retorica del “dover narrare” naturalista.
Oggi viene meno la forza analitica, la concretezza storica delle parole così come il contesto in cui si opera. Emblematico di questo impoverimento-disorientamento è la risposta secca di Niccolò al pedante amico fotografo: «Quante parole sono passate e ripassate nei nostri discorsi e il mondo là fuori diventa sempre più impenetrabile». Al caos di un mondano sempre più incomprensibile, che rende vane ed obsolete categorie fino a poco prima abili a comprenderne la complessità, si connette la certezza di un necessario cambio di passo analitico, interpretativo, senza tuttavia rinnegare le proprie scelte e convinzioni, senza far abdicare il proprio universo linguistico e simbolico al cinismo della cronaca quotidiana.
Non è di certo una novità. Antonioni ha sempre posto la questione del visibile e della visione (del rapporto tra soggetto ed oggetto) in primo piano. Tuttavia all’epoca, e prepotentemente oggi, il problema centrale su cui prestare attenzione è che ad una precarietà economico-sociale corrisponde una precarietà emotivo-sentimentale assoluta, dentro la quale si consuma la perdita di ogni tradizionale punto di riferimento su cui pensare ed articolare la costruzione del proprio Sé (che è sempre un Sé sociale) e del rapporto di questo Sé con il mondo, con gli oggetti che gli si oppongono. Una crisi antropologica generale (di cui parlava già Pasolini) che esorbita la coppia ma che trova nella coppia, nell’incapacità di concretizzare un legame, un sentimento, un’emozione, nel dare senso pratico al proprio sentire, che lacera i nostri tempi. Se la parola perde di significato, se il dire trasfigura regressivamente in “essere detti”, allora la critica viene meno. La realtà sociale si “naturalizza” e l’ovvio da eccezione diviene regola del vivere quotidiano. Il problema dunque ancora una volta è lo statuto ontologico, fisico-biologico dell’uomo nel mondo, nella sua capacità di produrlo con la propria prassi sociale, uscendo fuori dal suo atomismo individualista e dal suo egoismo egocentrico.; il recupero della socialità del sentimento come collante comunitario tra gli uomini.

Il terzo punto nasce inevitabilmente dal secondo. Dov’è la felicità e la bellezza dell’amore in tutto questo? È la domanda che si pone l’amico fotografo di Niccolò quando lo va a trovare. «Hai in mente un altro film d’amore? Ma io mi chiedo come si può parlare d’amore in questi sfacelo, in questa corruzione? » Ed è la stessa domanda che ci poniamo anche noi, in tempi non così diversi da quelli in cui il film è stato scritto (1981, scandalo P2, corruzione diffusa, crisi economica, tensione sociale, totale sfiducia nella politica, ecc).
Una domanda che ovviamente non ha risposta e che molto probabilmente mai l’avrà ed Antonioni , molto acutamente, non si arroga il diritto di porre una chiosa definitiva alla questione. Forse la soluzione sta nel non rinunciare a sognare, a vagabondare, ad inseguire una suggestione pur guardando senza paura, con in mano la propria esperienza-coscienza, quel mondo “grande e terribile” che – come disse Gramsci – ci atterrisce. Nell’uscire fuori di noi, abbracciare la realtà senza annacquarci indistintamente in essa. Comprenderla a fondo senza esserne complici. Amarla senza subirla. Forse è in questo crinale la risposta. In questa soglia, direbbe Agamben, in cui è ancora possibile dare un senso alla parola felicità, alla bellezza come prassi e non solo come chimerico traguardo da raggiungere, sigillo della fine dei tempi. La bellezza dell’amore è in ogni istante rubato, in un gesto involontario ed inatteso, in ogni scansione del nostro tempo, nel nostro “puro e semplice” essere al mondo. Continuare ad amare ed a desiderare, senza sapere perché, lasciarci anche ingannare dai fuochi fatui, lanciarci nel vuoto, tenere aperto lo sguardo nel buio, se ciò ci fa essere più vicino alla nostra intima natura, tirare fuori il male che coviamo per dargli forma concreta, esorcizzare i nostri demoni. Magari sognando di realizzare un film di fantascienza in cui anche l’elemento più inverosimile può sembrare, anzi è autentico nella sua utopica impossibilità.
Claudio Vettraino