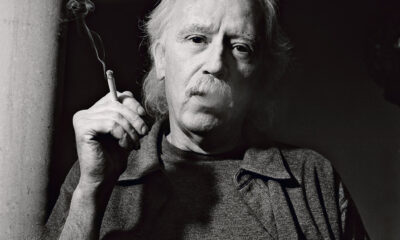Modelli di narrazione e drammaturgia ideologicamente non integrati al Sistema, oltre il paradigma “pop” e quello “concettuale” dell’estetica e dell’arte contemporanee
Segnaliamo una decina di testi audiovisivi di produzione “occidentale” degli ultimi quindici anni, che mettono sintomaticamente in discussione alcuni assiomi ideologici ed estetici della “società postmoderna” in nome delle aporie e conflittualità della coeva realtà politico-economico-culturale, sempre più slatentizzate sulla nostra scena mediale e simbolica dagli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 ad oggi.
I film (e la serie) citati si interrogano sui paradigmi culturali latenti e sulle tensioni intime dell’Occidente consumista e neoliberista contemporaneo, prediligendo visioni poetiche ancorate a un impellente dato e senso di “realtà” a discorsi proiettati su un orizzonte schiettamente metalinguistico e “warholiano” di decostruzione dei codici (e dei supporti) mediali e audiovisuali dominanti nell’attuale società mediatizzata.
I testi paiono altresì prospettare su questioni culturali nodali (il ruolo odierno degli intellettuali, l’eredità del patrimonio simbolico e solidaristico della tradizione occidentale, le finzioni e le rimozioni delle ideologie della globalizzazione e del multiculturalismo, le politiche e i dispositivi del neocapitalismo e del consumismo etc.) altrettante letture radicali che, demistificandone i paradossi e le contraddizioni interni, optino per le cornici estetiche del “dramma” [1] o dello “spettacolo” (con il suo impatto magniloquente), non snobbate quali registri espressivi virtualmente corrotti dalla società televisiva, ma declinate in nuove formule ibride e più o meno stranianti, lontane dai cliché della TV e delle “piattaforme mainstream”.
Riportiamo i titoli dei film e del telefilm, indicando per ciascuno di essi un focus tematico e concettuale.
MIA MADRE (2015) di Nanni Moretti: la solitudine e il fallimento pragmatico-politico dell’intellettuale snobisticamente avverso alle derive cognitive e culturali del sociale.
LE COSE BELLE (2013) di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno: i nuovi sguardi “critici” di sensibilità agenti per il sociale, seminali per la proliferazione di una presa di coscienza “dal basso” delle ferite diffuse di una cultura diseducativa, che annienta il valore e il significato del Tempo nell’eterno presente di un’adolescenza (e di un imperante “principio di piacere”) dalle mille promesse e seduzioni.
GOOD BYE, LENIN! (2003) di Wolfgang Becker: la fine delle grandi narrazioni e l’ironia del mondo postmoderno quali perdite e lutti simbolici e collettivi, rimossi nelle memorie e nei racconti del “privato” in uno strenuo e fallimentare sforzo compensativo.
MAD MEN (2007) di Matthew Weiner: la cultura dei simulacri e della pubblicità descritta quale universo socio-antropologico della violenza, delle rimozioni e dell’alienazione, dietro la coltre dei suoi segni patinati e autoreferenziali.
GOMORRA (2008) di Matteo Garrone: il feticismo e lo spettacolo del benessere trasposti in fantasma ossessivo e schizofrenico che tiene in piedi un ordine politico-economico di traffici e di morte.
LOURDES (2009) di Jessica Hausner: le esperienze dell’emarginazione, della malattia e della morte, tra il vissuto e i patimenti solitari dell’individuo, da un lato, e la rimozione totale da parte della cultura e della comunità, dall’altro.
IL CAVALIERE OSCURO (2008) di Christopher Nolan: la libido del Denaro come modello culturale anarcoide di eccessi e di una generalizzata e disincarnata pulsione di morte, temperato dalle “politiche della Paura” dello Stato neo-conservatore e della società mediatizzata.
INCEPTION (2010) di Christopher Nolan: il nuovo mondo globalizzato (e i correlati flussi migratori) quali innesti virali, spazio perturbante del disorientamento, mancata integrazione fra ceppi culturali nemici e competitivi, e, al fondo, vana ricerca dell’armonia di un habitat familiare perduto.
BIUTIFUL (2010) di Alejandro González Iñárritu: la violenza del mercato e il collasso di ogni struttura simbolico-estetico-sociale ereditata dalla ricchezza della tradizione occidentale: la sopravvivenza e la forza vitale e tutrice di simboli elementari e fortemente soggettivati, che esprimono il sentimento della “conservazione” e della “resistenza” all’ostilità dell’ambiente esterno.
BIRDMAN O (L’IMPREVEDIBILE VIRTÙ DELL’IGNORANZA) (2014) di Alejandro González Iñárritu: il teatro e il dramma dell’anarchia e della dissidenza culturale, messi in scena dal paradigma dell’autodistruzione di chi, pienamente integrato al Sistema cogente da un punto di vista ideologico, ne patisce sulla pelle, senza alcuna rete simbolica di protezione, le nefaste e fantasmatiche seduzioni.
Francesco Di Benedetto
[1] Sintomaticamente, l’estetica delle tensioni e delle lacerazioni interne dell’universo della finzione scenica, che in una narrazione letteraria, teatrale o cinematografica evidenzia e acutizza i conflitti interpersonali, psicologici e simbolici alla base dell’azione diegetica.
Bibliografia essenziale
Victor Turner, Dal rito al teatro, Il Mulino, Bologna 1986.
Zygmunt Bauman, Il disagio della postmodernità, Bruno Mondadori, Milano 2002.
Roberto Saviano, Gomorra, Mondadori, Milano 2006.
Massimo Recalcati, L’uomo senza inconscio, Raffaello Cortina, Milano 2010.